ASPETTI
BIOLOGICI ED ECOLOGICI DELLE "TEGNÙE":
BIOCOSTRUZIONE, BIODIVERSITÀ E SALVAGUARDIA
di Massimo Ponti
foto di Piero Mescalchin
Testo
tratto da:
Ponti, M. (2001) Aspetti biologici ed ecologici delle "tegnùe":
biocostruzione, biodiversità e salvaguardia. Chioggia, rivista
semestrale di studi e ricerche del Comune, 18: 179-194.
Le
immagini non si riferiscono ai testi ma hanno solo valenza descrittiva
della fauna presente.
"...
questo mare deve presentare una dimora opportuna alle produzioni sì
vegetabili che animali amanti d'abitazione d'indole disparata ... e
per conseguenza vi abbondano gli animali coperti d'integumenti duri
per lo più calcarei, i quali decomponendosi contribuiscono di nuovo a
formare concrezioni parimenti calcaree, che rendono quei letti
ineguali ed aspri ..."
Giuseppe
Olivi, 1792
Che
ad interrompere la monotonia delle distese sabbiose e fangose
nell'Adriatico settentrionale vi fossero delle formazioni rocciose,
substrato idoneo allo sviluppo di una flora e di una fauna peculiare,
e che infine gli organismi stessi potessero contribuire alla
formazione e all'accrescimento di queste strutture, era già ben noto
all'Abate Giuseppe Olivi che nel 1792 li descriveva con dovizia di
particolari nella sua opera "Zoologia Adriatica".
Con il nome popolare di "tenùe" vengono oggi indicate un
gran numero di rocce che affiorano dai sedimenti nord adriatici in una
vasta area tra Grado e le foci del fiume Brenta. Purtroppo fino quasi
ai giorni nostri, di questi ambienti, ostili ai pescatori che operano
con reti a strascico, nessuno o quasi si è più occupato, tant'è che
nemmeno Vatova nel 1949 ne fa menzione nella sua fondamentale opera di
descrizione della fauna bentonica dell'Alto e Medio Adriatico.
Ritornate agli onori della cronaca e all'attenzione della scienza a
partire dalla seconda metà degli anni sessanta grazie agli studi
geologici intrapresi da Stefanon e colleghi (Stefanon 1966, 1967,
1970; Braga & Stefanon 1969; Stefanon & Mozzi 1972; Newton
& Stefanon 1975) oggi questi ambienti sono oggetto di indagini da
parte di numerosi ricercatori sia nel campo della geologia (Newton
& Stefanon, 1982; Gabbianelli et al. 1997; Colantoni &
Taviani 1980; Colantoni et al. 1997a, 1997b, 1998) sia in
quello della biologia (Mizzan 1992, 1994, 1995; Cesari & Mizzan
1994; Gabriele et al. 1999). Nonostante questo sono ancora
molti gli aspetti da chiarire sia sulla formazione sia sull'evoluzione
di queste formazioni rocciose nonché sulla flora e la fauna ad esse
intimamente associate.
Biocostruzione
Fin dai primi studi è stato messo in evidenza come questi
affioramenti siano in realtà molto eterogenei presentando morfologie
e strutture molto variabili ed estensioni comprese tra pochi e
centinaia di metri quadrati. L'area di distribuzione include gran
parte dell'Adriatico settentrionale e l'intervallo batimetrico spazia
da 10 a 40 m di profondità.
 Secondo
i vari studi, la loro origine primaria, di cui qui non ci occuperemo,
appare comunque complessa e in alcuni casi può essere ricondotta ad
una iniziale cementazione carbonatica di sedimenti clastici (sabbie) e
bioclastici (gusci di conchiglie ed esoscheletri) che costituiscono lo
strato di base più o meno spesso; probabilmente in questi casi si
tratta di beachrocks formatesi circa 4.000 anni fa, quando il
livello del mare era più basso, sulle quali successivamente si sono
poi imposte forme organogene, direttamente generate cioè da organismi
biocostruttori. Nel favorire la cementazione dei clasti e lo sviluppo
di organismi biocostruttori appare importante, anche se non
completamente chiarito, il ruolo rivestito dalle emissioni di gas
metano presenti in corrispondenza di alcuni affioramenti e diffuse in
vaste aree dell'Adriatico settentrionale (Colantoni et al.
1997a, 1997b, 1998; Gabbianelli et al., 1997).
Secondo
i vari studi, la loro origine primaria, di cui qui non ci occuperemo,
appare comunque complessa e in alcuni casi può essere ricondotta ad
una iniziale cementazione carbonatica di sedimenti clastici (sabbie) e
bioclastici (gusci di conchiglie ed esoscheletri) che costituiscono lo
strato di base più o meno spesso; probabilmente in questi casi si
tratta di beachrocks formatesi circa 4.000 anni fa, quando il
livello del mare era più basso, sulle quali successivamente si sono
poi imposte forme organogene, direttamente generate cioè da organismi
biocostruttori. Nel favorire la cementazione dei clasti e lo sviluppo
di organismi biocostruttori appare importante, anche se non
completamente chiarito, il ruolo rivestito dalle emissioni di gas
metano presenti in corrispondenza di alcuni affioramenti e diffuse in
vaste aree dell'Adriatico settentrionale (Colantoni et al.
1997a, 1997b, 1998; Gabbianelli et al., 1997).
 Dal
punto di vista morfologico, Newton e Stefanon (1982) riferiscono
dell'esistenza di due tipologie fondamentali di "tegnùe":
da una parte veri e propri "reefs" o barriere
organogene interamente o quasi realizzate da organismi biocostruttori,
dall'altra rocce sedimentarie più o meno grandi e spesso in forma di
lastre su cui gli organismi creano solo sottili "croste" di
ricoprimento. Di fatto, qualunque corpo solido sommerso come ad
esempio i gusci di grossi bivalvi (ostriche, pinne e pettini), oggetti
abbandonati o relitti, possono costituire il fulcro di partenza per lo
sviluppo di organismi incrostanti che coi loro gusci o scheletri
calcarei si accrescono gli uni sugli altri, inglobando altri gusci e
sedimento, originando "biostrutture".
Dal
punto di vista morfologico, Newton e Stefanon (1982) riferiscono
dell'esistenza di due tipologie fondamentali di "tegnùe":
da una parte veri e propri "reefs" o barriere
organogene interamente o quasi realizzate da organismi biocostruttori,
dall'altra rocce sedimentarie più o meno grandi e spesso in forma di
lastre su cui gli organismi creano solo sottili "croste" di
ricoprimento. Di fatto, qualunque corpo solido sommerso come ad
esempio i gusci di grossi bivalvi (ostriche, pinne e pettini), oggetti
abbandonati o relitti, possono costituire il fulcro di partenza per lo
sviluppo di organismi incrostanti che coi loro gusci o scheletri
calcarei si accrescono gli uni sugli altri, inglobando altri gusci e
sedimento, originando "biostrutture".
 Nel
caso dei reefs propriamente detti i principali organismi
costruttori sembrano essere le alghe calcaree, seguite in ordine di
importanza dai madreporari, tra cui Cladocora caespitosa e Astroides
calycularis, briozoi e policheti serpulidi. Nel caso delle croste
di ricoprimento la componente di serpulidi appare più ridotta a
favore dei briozoi. La componente algale varia comunque da zona a zona
ed è principalmente influenzata dalla penetrazione della luce
(profondità e torbidità dell'acqua) e dai tassi di sedimentazione a
cui è sottoposta. In generale le biocostruzioni sono un fenomeno
complesso, ben rappresentato nelle zone tropicali ma presente e molto
importante anche nell'area mediterranea, con diversi aspetti e forme.
Tali strutture sono formate da popolamenti densi, spesso costituiti da
poche specie, a base di alghe calcaree sciafile che si sviluppano sia
su substrati duri sia mobili, in condizioni di scarsa luminosità. Il
concrezionamento è fondamentalmente legato a fattori quali la velocità
di crescita della specie algale dominante e il tasso di
sedimentazione. Le velocità di accrescimento per alcune "tegnùe",
desunte sulla base degli spessori raggiunti e delle datazioni
eseguite, sono tra 0.25 e 0.75 mm all'anno (Gabbianelli et al.
1997).
Nel
caso dei reefs propriamente detti i principali organismi
costruttori sembrano essere le alghe calcaree, seguite in ordine di
importanza dai madreporari, tra cui Cladocora caespitosa e Astroides
calycularis, briozoi e policheti serpulidi. Nel caso delle croste
di ricoprimento la componente di serpulidi appare più ridotta a
favore dei briozoi. La componente algale varia comunque da zona a zona
ed è principalmente influenzata dalla penetrazione della luce
(profondità e torbidità dell'acqua) e dai tassi di sedimentazione a
cui è sottoposta. In generale le biocostruzioni sono un fenomeno
complesso, ben rappresentato nelle zone tropicali ma presente e molto
importante anche nell'area mediterranea, con diversi aspetti e forme.
Tali strutture sono formate da popolamenti densi, spesso costituiti da
poche specie, a base di alghe calcaree sciafile che si sviluppano sia
su substrati duri sia mobili, in condizioni di scarsa luminosità. Il
concrezionamento è fondamentalmente legato a fattori quali la velocità
di crescita della specie algale dominante e il tasso di
sedimentazione. Le velocità di accrescimento per alcune "tegnùe",
desunte sulla base degli spessori raggiunti e delle datazioni
eseguite, sono tra 0.25 e 0.75 mm all'anno (Gabbianelli et al.
1997).

 Sui fondali di diverse piattaforme continentali mediterranee si
rinvengono concrezionamenti ad opera di alghe coralline, briozoi e
serpulidi di sedimenti detritici costieri contenenti ciottoli sabbia e
frammenti di conchiglie,. Gli organismi che costruiscono strutture di
carbonato di calcio portano ad una progressiva sovrapposizione di
strati calcarei, sui quali possono insediarsi un gran numero di
organismi, sia massivi sia eretti. L'attività concrezionante è in
parte bilanciata da organismi perforatori quali clionidi e alghe
endolitiche (Cerrano et al. 1999). Le alghe calcaree sono
Rhodophyta (alghe rosse) appartenenti alla famiglia delle Corallinacee.
In queste alghe la parete è impregnata di carbonato di calcio (CaCO3)
depositato sotto forma di calcite o aragonite. Vivono in genere fino a
20 m di profondità anche in zone ad elevato idrodinamismo dove
possono dare vere e proprie formazioni rocciose. Le specie più note
sono Mesophyllum lichenoides, Lithophyllum spp., Pseudolithophyllum
spp. e Lithothamnion spp. Fra le specie calcaree vi sono poi
delle forme ramificate e grandi qualche centimetro (dei generi Lithophyllum
e Lithothamnion) chiamate generalmente "praline" o
col termine bretone "maërl"; si tratta di "bentopleustofite"
che vagano ruzzolando spinte dalle correnti e finiscono per
accumularsi in zone depresse più o meno profonde dove insieme a
briozoi, coralli e gusci di molluschi possono formare anche grandi
depositi di Rhodoliti, così come li chiamano i geologi. Piccoli
banchi di maërl sono presenti anche in alcune zone dell'Adriatico
settentrionale a profondità comprese fra i 30 e i 70 m e non si
esclude che alcuni di questi potrebbero costituire la base per la
formazione di "tegnùe" profonde.
Sui fondali di diverse piattaforme continentali mediterranee si
rinvengono concrezionamenti ad opera di alghe coralline, briozoi e
serpulidi di sedimenti detritici costieri contenenti ciottoli sabbia e
frammenti di conchiglie,. Gli organismi che costruiscono strutture di
carbonato di calcio portano ad una progressiva sovrapposizione di
strati calcarei, sui quali possono insediarsi un gran numero di
organismi, sia massivi sia eretti. L'attività concrezionante è in
parte bilanciata da organismi perforatori quali clionidi e alghe
endolitiche (Cerrano et al. 1999). Le alghe calcaree sono
Rhodophyta (alghe rosse) appartenenti alla famiglia delle Corallinacee.
In queste alghe la parete è impregnata di carbonato di calcio (CaCO3)
depositato sotto forma di calcite o aragonite. Vivono in genere fino a
20 m di profondità anche in zone ad elevato idrodinamismo dove
possono dare vere e proprie formazioni rocciose. Le specie più note
sono Mesophyllum lichenoides, Lithophyllum spp., Pseudolithophyllum
spp. e Lithothamnion spp. Fra le specie calcaree vi sono poi
delle forme ramificate e grandi qualche centimetro (dei generi Lithophyllum
e Lithothamnion) chiamate generalmente "praline" o
col termine bretone "maërl"; si tratta di "bentopleustofite"
che vagano ruzzolando spinte dalle correnti e finiscono per
accumularsi in zone depresse più o meno profonde dove insieme a
briozoi, coralli e gusci di molluschi possono formare anche grandi
depositi di Rhodoliti, così come li chiamano i geologi. Piccoli
banchi di maërl sono presenti anche in alcune zone dell'Adriatico
settentrionale a profondità comprese fra i 30 e i 70 m e non si
esclude che alcuni di questi potrebbero costituire la base per la
formazione di "tegnùe" profonde.
 Fra gli organismi
biocostruttori animali possiamo ricordare Cladocora caespitosa
che è una sclerattinia coloniale endemica del Mediterraneo in grado
di produrre simbiosi con zooxanthelle come quelle che si osservano
nelle barriere coralline tropicali. Essa è in grado di vivere in un
ampio intervallo ecologico: su fondi duri o molli, in acque calme o
mosse, dalla superficie a circa 50 m di profondità. Tali parametri
sono in grado di influenzare profondamente la forma generale della
colonia, che si presenta comunque composta da rametti aventi i calici
sempre rivolti verso l'alto. Normalmente tale madrepora si considera
aermatipica (non è cioè in grado di costruire barriere), ma in
alcune aree sono noti veri e propri banchi: in Corsica, Tunisia e a
Ustica si conoscono banchi ormai morti e ricoperti da sedimenti, nel
golfo di Atalanti e nello stretto tra Eubea e la terraferma esistono
invece formazioni ancora viventi. Un grande numero di invertebrati
vive tra i rami di C. caespitosa ma i poriferi sono i più
rappresentati. In particolare, i clionidi sono i principali
responsabili della distruzione di tali strutture (Cerrano et al.
1999). Tra i policheti serpulidi che contribuiscono a queste strutture
troviamo Serpula concharum, S. vermicularis, Pomatoceros
triqueter, Protula tubularia (Boldrin 1979). Si tratta di
anellidi in grado di costruire tubi calcarei, più o meno lunghi e
contorti, in cui si rifugiano. Lo sviluppo di alcune specie è tale da
formare anche nel giro di pochi decenni estesi reefs, ben noti
quelli lagunari realizzati da Ficopomathus enigamaticus.
Fra gli organismi
biocostruttori animali possiamo ricordare Cladocora caespitosa
che è una sclerattinia coloniale endemica del Mediterraneo in grado
di produrre simbiosi con zooxanthelle come quelle che si osservano
nelle barriere coralline tropicali. Essa è in grado di vivere in un
ampio intervallo ecologico: su fondi duri o molli, in acque calme o
mosse, dalla superficie a circa 50 m di profondità. Tali parametri
sono in grado di influenzare profondamente la forma generale della
colonia, che si presenta comunque composta da rametti aventi i calici
sempre rivolti verso l'alto. Normalmente tale madrepora si considera
aermatipica (non è cioè in grado di costruire barriere), ma in
alcune aree sono noti veri e propri banchi: in Corsica, Tunisia e a
Ustica si conoscono banchi ormai morti e ricoperti da sedimenti, nel
golfo di Atalanti e nello stretto tra Eubea e la terraferma esistono
invece formazioni ancora viventi. Un grande numero di invertebrati
vive tra i rami di C. caespitosa ma i poriferi sono i più
rappresentati. In particolare, i clionidi sono i principali
responsabili della distruzione di tali strutture (Cerrano et al.
1999). Tra i policheti serpulidi che contribuiscono a queste strutture
troviamo Serpula concharum, S. vermicularis, Pomatoceros
triqueter, Protula tubularia (Boldrin 1979). Si tratta di
anellidi in grado di costruire tubi calcarei, più o meno lunghi e
contorti, in cui si rifugiano. Lo sviluppo di alcune specie è tale da
formare anche nel giro di pochi decenni estesi reefs, ben noti
quelli lagunari realizzati da Ficopomathus enigamaticus.
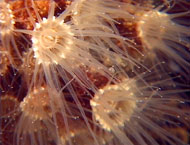 Biodiversità
Biodiversità
Indipendentemente da come questi affioramenti rocciosi si siano
generati, tutti rappresentano substrati duri isolati che consentono
localmente l'insediamento di una fauna e una flora bentoniche
peculiari e sostanzialmente diverse rispetto a quelle rinvenibili nei
circostanti fondi mobili. Mentre nei sedimenti, a seconda della
composizione e granulometria, si rinvengono infaune costituite
principalmente da policheti, bivalvi e gasteropodi fossori a cui si
affiancano alcuni echinodermi e crostacei (Vatova 1949; Peres &
Picard 1964; Gamulin-Brida 1974), sui fondi duri è possibile
l'insediamento di epibionti sessili, che vivono cioè saldamente
attaccati al substrato. Tra questi si possono ricordare alcuni
celenterati, poriferi incrostanti o eretti come Verongia aerophoba
e Axinella sp., policheti, bivalvi, crostacei cirripedi,
briozoi e tunicati come ad esempio Polycitor adriaticus e Aplidium
conucum. All'interno delle rocce calcaree possono inoltre
insediarsi endobionti come poriferi e bivalvi endolitici (Gabriele et
al. 1999). Grazie alle cavità e agli interstizi presenti, più o
meno riempiti di sedimento, possono trovare qui rifugio anche
moltissime specie mobili, comprese alcune di quelle che albergano nei
sedimenti circostanti. In genere è possibile riscontrare una elevata
presenza di crostacei e di echinodermi, tra i quali prevale la specie
di ofiura Ophiothrix fragilis, non mancano poi nudibranchi,
cefalopodi, platelminti, sipunculidi, nemertini ed echiuridi. Questi
ambienti sono inoltre favorevoli per la riproduzione e lo sviluppo
degli stadi giovanili di molte specie offrendo loro protezione e
riducendo così la mortalità. In definitiva, la presenza di substrati
duri nonché di nicchie e gradienti ambientali inducono un aumento
della diversità specifica (Bisby 1995). Anche la fauna ittica
associata a questi ambienti è particolarmente ricca e diversificata.
Infatti possono trovare protezione e alimento pesci bentonici come
gronghi, piccoli serranidi, corvine, saraghi, labridi, blennidi,
scorfani e triglie. Spesso anche banchi di pesci pelagici, o comunque
meno legati al fondale, vengono attratti dalla presenza di queste
oasi, come nel caso di boghe, occhiate, merluzzi e sardine. Questo
fenomeno di attrazione, già noto ai pescatori e particolarmente
studiato per i "reefs artificiali", può essere
ricondotto a 5 tipologie di comportamento dei pesci: reotassia
(orientamento rispetto alla corrente), geotassia (orientamento
rispetto alla costa e alla morfologia del fondale), tigmotassia
(ricerca del contatto fisico), fototassia (risposta alla luce e
all'ombra), chemiotassia (risposta a stimoli chimici/olfattivi). In
realtà è molto difficile comprendere per alcune specie se l'elevata
densità che si riscontra è semplicemente frutto di una attrazione e
concentrazione a discapito dei fondali circostanti o se questi
ambienti supportino un reale aumento della fauna ittica e quindi un
aumento della produttività (Neves Santos et al. 1997).
In generale, nonostante le ridotte
profondità, a causa della frequente torbidità dell'acqua si osserva
una prevalenza di forme animali rispetto a quelle vegetali. In questo
mare eutrofico osserviamo stagionalmente l'abbondate sviluppo nella
colonna d'acqua di microalghe planctoniche che rappresentano gran
parte della produzione primaria da cui trae origine la rete trofica.
Il fotoplancton costituisce infatti cibo per lo zooplancton. Insieme,
particellato organico trasportato dei fiumi, fito- e zooplancton,
costituiscono alimento per moltissimi organismi bentonici filtratori e
sospensivori, che in genere dominano le comunità delle tegnùe. Da
qui le rete trofica prosegue fino ai grandi predatori (es.: Homarus
gammarus, Maja squinado) mentre parallelamente si
sviluppano gli organismi detritivori e decompositori. La grande
disponibilità alimentare e la presenza di comunità ricche e
diversificate consentono una elevata produzione di biomassa. La
composizione floro-faunistica è localmente condizionata dai rapporti
iter- e intraspecifici come competizione, predazione e varie tipologie
di simbiosi. Fattori ambientali che possono influenzare l'insediamento
e l'abbondanza delle diverse specie sono l'idrodinamismo, i tassi di
sedimentazione, la profondità e la torbidità media delle acque che
condiziona la penetrazione della luce e quindi la sopravvivenza delle
forme vegetali. Anche la presenza di inquinanti o di altri fenomeni di
disturbo, naturale o antropico, possono condizionare le diverse
popolazioni ed i rapporti reciproci. Per questo motivo affioramenti più
o meno lontani dalle coste, sotto l'influenza o meno di foci fluviali
o di scarichi civili e industriali possono presentare comunità
bentoniche anche molto diverse tra loro.
In Adriatico settentrionale oltre alle tegnùe vi sono moltissimi
altri reefs "artificiali", alcuni sono stati
intenzionalmente costruiti per scopi specifici come le piramidi di
blocchi di cemento o di altri materiali, deposti per creare zone di
ripopolamento e proteggere alcuni ambienti impedendo localmente la
pesca a strascico (Bohnsack & Sutherland 1985; Bombace et al.
1994, 1997; Bombace 1989, 1997), oppure nel caso di opere portuarie e
di altre opere di difesa costiera (pennelli, scogliere frangiflutti
emerse, sommerse o soffolte, scogliere radenti, ecc.; Airoldi et al.
2000) o anche nel caso di strutture offshore connesse allo
sfruttamento dei giacimento metaniferi (Falace & Bressan 1997;
Bombace et al. 1999; Fabi et al. 1999). Costituiscono reef
artificiali anche diversi relitti tra i quali il più famoso e
studiato è quello della piattaforma di perforazione Agip
"Paguro" (Ponti et al. 1998, 1999, 2000; Giovanardi
& Rinaldi 1999). Confrontando alcuni reefs naturali con
alcuni artificiali sono state osservate comunità sostanzialmente
diverse tra loro. Ad esempio il numero di specie di poriferi in genere
è maggiore sui substrati naturali ma cala all'aumentare della
torbidità dell'acqua. Al contrario i bivalvi e i policheti sembrano
essere rappresentati da un maggior numero di specie sui substrati
artificiali, dove in particolare è caratteristica la presenza di
ostriche (Ostrea edulis, Crassotrea gigas) e cozze (Mytilus
galloprovincialis). Le comunità dei substrati naturali invece si
caratterizzano per l'elevata presenza di specie di ascite, tra cui
domina Polycitor adriaticus. Queste differenze appaiono però
principalmente dovute non tanto alla diversa natura del substrato
quanto alla diversa elevazione dal fondale, la diversa torbidità
delle acque, la presenza sulle barriere artificiali di pareti
verticali sulle quali l'accumulo dei sedimenti è ridotto (Gabriele et
al. 1999).
 Salvaguardia
Salvaguardia
Le tegnùe rappresentano ambienti particolarmente importanti dal punto
di vista naturalistico sia perché aumentano la biodiversità dei
fondali adriatici sia perché offrono alimento e protezione a numerose
specie favorendone la riproduzione e riducendo la mortalità.
Purtroppo però sono ambienti delicati che possono risentire
negativamente di fenomeni di disturbo sia naturali, come nel caso di
massicci apporti di sedimenti alluvionali, sia antropici. Tra questi
ultimi costituiscono gravi minacce l'inquinamento, la discarica di
rifiuti, la pesca indiscriminata con strumenti atti a raschiare il
fondale, l'ancoraggio. Persino un'eccessiva presenza di subacquei non
opportunamente sensibilizzati sulla vulnerabilità di questi ambienti
potrebbe localmente creare danni ai popolamenti soprattutto delle
specie erette (Davis & Tisdell 1995). Data la ridotta elevazione
anche le crisi anossiche, che periodicamente di verificano nei pressi
dei fondali in seguito ai fenomeni eutrofici e alla stratificazione
della colonna d'acqua, possono causare seri danni alle comunità. Ad
esempio, a seguito di una importante crisi, nel 1977 Boldrin (1979)
osservò danni alle popolazioni di poriferi, echinodermi, crostacei,
bivalvi tra cui Pinna nobilis, ed inoltre i pescatori e
ricercatori assistettero ad un accumulo verso costa e alla moria di un
gran numero di pesci ed astici (Scovacricchi 1998). La realizzazione
di impianti di maricoltura o di strutture artificiali finalizzate al
ripopolamento ittico, in alcuni casi proposte all'interno delle aree
ove le tegnùe sono più abbondanti (Mascarello et al. 1998),
andrebbe valutata con molta attenzione dato che questi potrebbero
essere fonte di accumulo di detriti organici con un conseguente
impatto negativo a breve e lungo termine sui delicati equilibri
ecologici che consentono lo sviluppo e l'accrescimento di queste
strutture organogene (Molina Domýnguez et al. 2001; Mazzola
& Sarà 2001; Kraufvelin et al. 2001; Karakassis et al.
1999, 2000). Seguendo l'esempio delle esperienze condotte in diversi
stati europei, oggi anche nell'ambito delle tegnùe sono allo studio
interventi di ripopolamento di una importante e pregiata specie il cui
eccessivo sfruttamento nonché le crisi anossiche hanno causato negli
anni una forte contrazione degli stock: si tratta dell'astice Homarus
gammarus. I primi risultati prodotti dalla sperimentazione in
campo appaiono confortanti (Scovacricchi 1997, 1998a, 1998b;
Scovacricchi & Burton 1998).
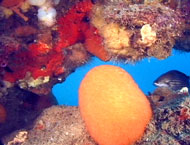
Nell'ambito
di una corretta ed oculata gestione costiera integrata andrebbero
previsti interventi a tutela almeno di una parte di questi ambienti
così importanti e delicati. In questo contesto appare molto
interessante ed appropriata la proposta del Comune di Chioggia, in
accordo con le associazioni di pesca e col supporto degli enti di
ricerca, di istituire una zona di tutela biologica. Le zone di tutela
biologica in particolare vengono istituite mediante decreto del
Ministero delle Politiche Agricole, di concerto con i vari organi ed
enti competenti in materia sia a livello locale che nazionale, ai
sensi della Legge 963 del 1965 e del DPR 1639 del 1968 e successive
modifiche, ai fini di salvaguardia e di ripopolamento delle risorse
marine (Diviacco 1999). Queste aree vengo individuate mediante
appositi studi scientifici che ne comprovino l'importanza per la
riproduzione o l'accrescimento di specie marine di rilievo economico.
Pur non essendo esplicitamente prevista una gestione attiva è
comunque possibile prevedere azioni di sviluppo nonché attività
didattiche e ricreative compatibili. Un particolare esempio in tal
senso è offerto dal relitto della piattaforma di perforazione Agip
"Paguro", affondata al largo di Ravenna a seguito di un
incidente nel 1965, e dal 1995 zona di tutela biologica e importante
meta turistica. In questo caso, grazie alla gestione da parte
dell'associazione "Paguro" e al controllo operato dalla
Capitaneria di Porto, la presenza dei subacquei appare compatibile con
la tutela dell'ambiente (Ponti et al. 2000). La proposta di
istituire una zona di tutela biologica, presentata al pubblico dal
Sindaco Dott. Fortunato Guarnieri in occasione della conferenza
tenutasi a Chioggia il 9 dicembre scorso, ha già intrapreso l'iter
burocratico e presto si avranno le prime risposte concrete. Nonostante
questo è necessario approfondire le conoscenze scientifiche su questi
ambienti e promuovere nuovi progetti di ricerca. In questo contesto,
oltre all'applicazione delle più moderne tecniche di indagine
scientifica e di sperimentazione in ambiente, sarà possibile,
seguendo le esperienze americane e australiane ma anche quelle
italiane, coinvolgere anche i subacquei sportivi, che frequentano in
gran numero le tegnùe così come i relitti in particolare quello del
"Paguro", in attività di censimenti visivi finalizzati alla
valutazione dell'abbondanza di alcune specie di facile riconoscimento
ma al contempo di elevato interesse ecologico ed economico. Fra le
specie da censire vi sono ad esempio l'astice e il grongo. Le
informazioni ricavabili in questo modo, se adeguatamente predisposte
ed analizzate, pur tenendo conto degli innegabili limiti di
accuratezza e precisione derivanti dall'inesperienza dei subacquei,
possono comunque fornire un importante contributo all'ampliamento
delle conoscenze sulla biodiversità di questi ambienti. A tal fine
vari enti di ricerca nazionali stanno predisponendo degli "Underwater
Watching Project" in grado di coinvolgere e coordinare in
modo opportuno i tanti subacquei sportivi.
Letteratura
citata:
Airoldi
L, Abbiati M, Aberg P, Burchart H, Ceccherelli VU, Hawkins SJ,
Lamberti A, Martin D, Van der Veen A, Vidal C (2000) Promoting
environmentally compatible design of coastal defence structures: a
European-scale project. Fluttuazioni Anomalie Recupero. Riassunti del
2° Convegno Nazionale delle Scienze del Mare, Genova 84-85.
Bisby
FA (1995) Characterization of biodiversity. In: Heywood VH, Watson RT
(eds) Global biodiversity assessment. Cambridge University Press,
Cambridge, p 21-106.
Bohnsack
JA, Sutherland DL (1985) Artificial reef research: a review with
recommendations for future priorities. Bulletin of Marine Science 37:
11-39.
Boldrin
A (1979) Aspetti ecologici delle formazioni rocciose dell'Alto
Adriatico. Convegno Scientifico Nazionale P. F. Oceanografia e Fondi
Marini, Roma.
Bombace
G (1989) Artificial reefs in the Mediterranean Sea. Bulletin of Marine
Science 44: 1023-1032.
Bombace
G (1997) Protection of biological habitats by artificial reefs.
European Articial Reef Research. Proceeding of the 1st EARRN
conference, Ancona, Italy 1-15
Bombace
G, Castriota L, Spagnolo A (1997) Benthic communities on concrete and
coal-ash blocks submerged in an artificial reef in the central
Adriatic Sea. Proceedings of the 30th European Marine Biological
Symposium, Southampton, UK 281-290.
Bombace
G, Fabi G, Fiorentini L, Speranza S (1994) Analysis of the efficacy of
arificial reefs located in five different areas of the Adriatic Sea.
Bulletin of Marine Science 55: 559-580.
Bombace
G, Fabi G, Rivas G. (1999) Effetti sul popolamento ittico indotti da
una piattaforma estrattiva dell'alto Adriatico: prospettive di
gestione delle risorse costiere. Biologia Marina Mediterranea, 5.
Braga
G, Stefanon A (1969) Beachrock ed Alto Adriatico: aspetti
paleogeografici, climatici, morfologici ed ecologici del problema.
Atti Ist. Veneto Sc. Lettere ed Arti 127: 351-366.
Cerrano
C, Ponti M, Silvestri S (1999) Guida alla biologia marina del
Mediterraneo. Manuale adottato nei corsi della Federazione Italiana
Attività Subacquee. R.D.E., Milano. 320.
Cesari
P, Mizzan L (1994) Dati sulla malacofauna marina costiera del
veneziano. Boll. Mus. civ. St. Nat. Venezia.
Colantoni
P, Gabbianelli G, Ceffa L (1997a) Methane venting and authigenic
carbonate formation in the Adriatic Sea. Proceeding of Int. Field
Workshop "Cold-e-vent: hydrocarbon seepage and chemiosynthesis",
Bologna 56.
Colantoni
P, Gabbianelli G, Ceffa L, Ceccolini C, Ricchiuto T (1998) Bottom
features and gas seepages in the Adriatic Sea. Proceeding of V
International conference on gas in marine sediments, Bologna 28-31.
Colantoni
P, Gabbianelli G, Ricchiuto T, Ceffa L (1997b) Methane-derived
cementation of recent sediments from the Adriatic continental shelf.
Proceeding of 18th IAS Regional European Meeting of Sedimentology GAEA,
Heidelberg 56.
Colantoni
P, Taviani M (1980) Esplorazione diretta dei fondali dell'Alto
Adriatico tra la foce del fiume Reno e la laguna Veneta. C.N.R. Prog.
Finalizz. Oceanogr. e fondi marini, Davis D, Tisdell C (1995)
Recreational scuba-diving and carrying capacity in marine protected
areas. Ocean & Coastal Management 26: 19-40.
Diviacco,
G (1999) Aree Protette Marine. Finalità e gestione. Comunicazione,
Santa Sofia (FO). 191.
Fabi
G, Lucchetti A, Trovarelli L (1999) Evolution of the fish assemblages
around a gas platform in the northern Adriatic Sea. Proceedings
Seventh International Conference on Atificial Reefs (7th CARAH),
Sanremo, Italy 454-461.
Falace
A, Bressan G (1997) Some observations on algal colonisation of
articial structures situated in the proximity of underwater pipes off
Lignano-Grado (north Adriatic Sea). Proceedings of the 30th European
Marine Biological Symposium, Southampton, UK 313-318.
Gabbianelli
G, Colantoni P, Degetto S, Dinelli E, Lucchini F (1997) Contributi
sedimentologici, geochimici ed isotopici per una caratterizzazione
ambientale dell'Adriatico settentrionale. Atti 1° Forum Italiano
delle Scienze della Terra, Bellaria 242-243.
Gabriele
M, Bellot A, Gallotti D, Brunetti R (1999) Sublittoral hard substrate
communities of the northern Adriatic Sea. Cahier de Biologie Marine
40: 65-76.
Gamulin-Brida
H (1974) Biocoenoses benthiques de la Mer Adriatique. Acta Adriatica
15: 1-103.
Giovanardi
O, Rinaldi A (1999) Effects of decommissioned offshore structures on
renewable resources in the Adriatic Sea. Proceeding of the Offshore
Mediterranean Conference OMC99, Ravenna 1121-1132.
Karakassis
I, Hatziyanni E, Tsapakis M, Plaiti W (1999) Benthic recovery
following cessation of fish farming: a series of successes and
catastrophes. Marine Ecology Progress Series 184: 205-218.
Karakassis
I, Tsapakis M, Hatziyanni E, Papadopoulou KN, Plaiti W (2000) Impact
of fish farming on the seabed in three Mediterranean coastal areas.
ICES Journal of Marine Science 57: 1462-1471.
Kraufvelin
P, Sinisalo B, Leppäkoski E, Mattila J, Bonsdorff E (2001) Changes in
zoobenthic community structure after pollution abatement from fish
farms in the Archipelago Sea (N. Baltic Sea). Marine Environmental
Research 51: 229-245.
Mascarello
F, Radaelli G, Colombo L, Dalla Valle L, Zanella L, Chillemi G,
Borella S, Segato S, Andrighetto I (1998) Indagini preliminari per
l'insediamento di un impianto pilota di maricoltura integrata nelle
acque tegnue di Caorle. Atti del Convegno Le ricerche sulla pesca e
sull'acquacoltura nell'ambito della legge 41/82 - parte terza
Acquacoltura, Igiene, economia, 15-16 Dicembre 1998 Roma. Biologia
Marina Mediterranea 5: 1744-1753.
Mazzola
A, Sarà G (2001) The effect of fish farming organic waste on food
availability for bivalve molluscs (Gaeta Gulf, Central Tyrrhenian, MED):
stable carbon isotopic analysis. Aquaculture 192: 361-379.
Mizzan
L (1992) Malacocenosi e faune associate in due stazioni altoadriatiche
a substrati solidi. Boll. Mus. civ. St. Nat. Venezia 41: 7-54.
Mizzan
L (1994) Malacocenosi in due stazioni altoadriatiche a substrati
solidi (2): analisi comparativa tra popolamenti di substrati naturali
ed artificiali. Lavori Soc. Ven. Scien. Nat. 18: 83-88.
Mizzan
L (1995) Le "tegnùe". Substrati solidi naturali del
litorale veneziano: potenzialità e prospettive. ASAP Azienda Sviluppo
Acquacoltura Pesca, Venezia. 46.
Molina
Dom_nguez L, Lopez Calero G, Vergara Mart_n JM, Robaina Robaina L
(2001) A comparative study of sediments under a marine cage farm at
Gran Canaria Island (Spain). Preliminary results. Aquaculture 192:
225-231.
Neves
Santos M, Costa Montiero C, Lassèrre G (1997) Finfish attraction and
fisheries enhancement on artificial reefs: a review. European Articial
Reef Research. Proceeding of the 1st EARRN conference, Ancona, Italy
97-114.
Newton
RS, Stefanon A (1975) The "Tegnue de Ciosa" area: patch
reefs in the northern Adriatic Sea. Maine Geology 8: 27-33.
Newton
RS, Stefanon A (1982) Side-scan sonoar and subbottom profiling in the
northern Adriatic Sea. Maine Geology 46: 279-306.
Olivi,
G (1792) Zoologia Adriatica. Reale Accademia Sc. Lettere Arti, Bassano.
334.
Peres
JM, Picard J (1964) Nouveau manuel de bionomie benthique de la Mer Méditerranée.
Recueil des Travaux de la Station Marine d'Endoume 31: 1-138.
Ponti
M, Abbiati M, Ceccherelli VU (1999) Drilling-platform wrecks as
artificial reefs: preliminary description of macrobenthic assemblages
of the "Paguro" (northern Adriatic). Proceedings Seventh
International Conference on Atificial Reefs (7th CARAH), Sanremo,
Italy 470-476.
Ponti
M, Capra A, Gabbianelli G, Ceccherelli VU (1998) Environmental
characterisation and macrobenthic communities of the Northern Adriatic
"Paguro" Wreck. Rapport du 35e Congrès de la Commission
Internationale pour l'Exploration Scientifique de la mer Méditerranée,
Dubrovnik (Croatie) 478-479.
Ponti
M, Fucci G, Gabbianelli G, Rinaldi A (2000) L'area di tutela biologica
"Paguro" (Adriatico settentrionale). Fluttuazioni Anomalie
Recupero. 2° Convegno Nazionale delle Scienze del Mare CoNISMa,
Genova 258-259.
Scovacricchi
T (1997) Tentativi di produzione di giovanili di astice europeo
Homarus gammarus L. (Decaposa Nephropidae) per il ripopolamento di
tegnue (beachrock outcrops) alto-adriatiche. Relazione annuale per il
progetto del Ministero Risorse Agricole Alimentari e Forestali.
Scovacricchi
T (1998a) Astici da semina per le "tegnùe". Un progetto
dell'Istituto di Biologia del Mare per ripopolare di Homarus l'Alto
Adriatico. Il Gazzettino 20:
Scovacricchi
T (1998b) Primi tentativi di rafforzamento degli stock di astice,
Homarus gammarus (Linnaeus, 1758), in Alto Adriatico. Atti del
Convegno Le ricerche sulla pesca e sull'acquacoltura nell'ambito della
legge 41/82 - parte terza Acquacoltura, Igiene, economia, 15-16
Dicembre 1998 Roma. Biologia Marina Mediterranea 5: 1455-1464
Scovacricchi
T, Burton CA (1998) Lobster (Homarus gammarus L.) Research in the
northern Adriatic Sea. The Lobster Newsletter 1: 11.
Stefanon
A (1966) First notes on the discovery of outcrops of beach rock in the
Gulf of Venice (Italy). XX Congrès - Assemblée Plenière de la
C.I.E.S.M.M. in Rapp. Comm. int. Mer. Médit. 648-649.
Stefanon
A (1967) Formazioni rocciose del bacino dell'Alto Adriatico. Atti Ist.
Veneto Sc. Lettere ed Arti 125: 79-89.
Stefanon
A (1970) The role of beachrock in the study of the evolution of the
North Adriatic Sea. Mem. Biogeogr. Adriatic. 8: 79-99.
Stefanon
A, Mozzi C (1972) Esistenza di rocce organogene nell'Alto Adriatico al
largo di Chioggia. Atti Ist. Veneto Sc. Lettere ed Arti 130: 495-499.
Vatova
A (1949) La fauna bentonica dell'Alto e Medio Adriatico. Nuova
Thalassia 1: 1-110